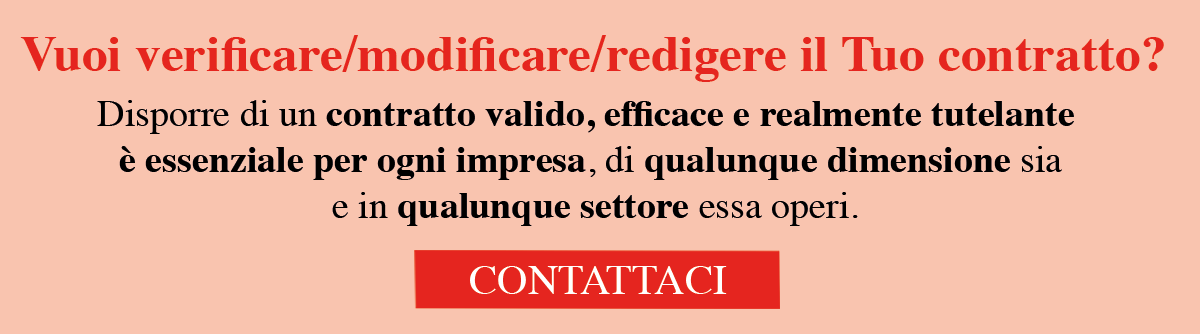Le joint ventures: profili legali
La joint venture (JV) è un accordo di collaborazione tra due o più imprese che intendono sviluppare un progetto comune. Il motivo che spinge le imprese a costituire una JV è l’esigenza di realizzare obiettivi economici che, per diversi motivi, non potrebbero essere raggiunti, o non potrebbero esserlo con tempi e costi sopportabili, da una singola impresa. Sotto il profilo giuridico, le JV si distinguono in contrattuali o societarie. Le prime sono accordi associativi, solitamente utilizzati per raggiungere degli obiettivi ben individuati e, il più delle volte, destinate a durare solo per il tempo necessario a raggiungere tali business targets. Le JV societarie sono invece accordi con cui due o più imprese, per raggiungere uno scopo comune prefissato, costituiscono una società autonoma e distinta rispetto ai singoli componenti; esse sono generalmente alla base di collaborazioni complesse e di più ampio respiro rispetto a quelle cui danno vita le JV contrattuali. Generalmente, le JV richiedono un investimento significativo in termini di risorse finanziarie, tempo e attenzione da parte del management. È pertanto opportuno redigere molto attentamente il contratto di JV, il principale, se non unico, strumento che governa la relazione tra i partner e previene le future dispute.
1. Caratteristiche e finalità della joint venture
La joint venture (JV) è un accordo di collaborazione tra due o più imprese che intendono sviluppare un progetto comune, e decidono di mettere in comune le reciproche capacità, risorse e conoscenze allo scopo di ottenere un risultato condiviso e di beneficio per tutti.
Il motivo che spinge le imprese partecipanti alla JV (ventures) ad impegnarsi reciprocamente è la realizzazione di obiettivi economici profittevoli che, per diversi motivi, non potrebbero essere raggiunti, o non potrebbero esserlo con tempi e costi sopportabili, dalle singole imprese.
Le JV vengono spesso costituite quando un’impresa ha intenzione di entrare in un nuovo mercato o quando si rende necessario utilizzare tecnologia di terze parti per sfruttare al meglio determinate opportunità di mercato. Generalmente, le JV richiedono un investimento significativo in termini di risorse finanziarie, tempo e attenzione da parte del management.
Le ragioni economiche che possono spingere due o più imprese a collaborare costituendo una JV sono molteplici:
- l’esigenza dei partecipanti si condividere gli sforzi ed i costi di un’attività di ricerca e sviluppo;
- l’esigenza di ottimizzare un processo produttivo;
- l’esigenza di acquistare (congiuntamente) materie prime, scorte o servizi;
- l’esigenza di esplorare un nuovo territorio o mercato;
- l’esigenza di aggirare (attraverso la JV con un socio locale) normative che impongono tassazioni elevate agli investimenti stranieri;
etc.
Inoltre, una JV può consentire molteplici vantaggi, quali l’accesso alla rete o alla tecnologia del partner, la creazione di opportunità di apprendimento (ad es. per quanto riguarda il modo di lavorare del partner), risparmi sui costi ( ad es. con acquisti congiunti, o produzione congiunta), la condivisione del rischio, l’accesso a nuovi mercati, la creazione di un canale distributivo (ad es. ampliamento della base clienti).
Tra tutte le diverse forme di aggregazione tra imprese, la JV è sicuramente la più elastica; per tale motivo essa si presta particolarmente ad essere utilizzata anche in ambito internazionale, dove contribuisce ad abbattere i rischi d’ingresso nei nuovi mercati, permettendo la condivisione di questi ultimi con un partner estero. Ciò assume particolare rilevanza soprattutto quando si tratta di Paesi lontani e non omogenei culturalmente con i nostri.
Molte imprese decidono di costituire all’estero filiali, sedi secondarie o società controllate; spesso, tuttavia due o più imprese necessitano di un accordo di collaborazione-qual è appunto la JV- che permetta loro di mantenere la propria indipendenza giuridica pur collaborando per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale, che preveda un utilizzo sinergico delle risorse delle singole imprese ed un’equa suddivisione dei rischi legati all’investimento.
Le JV necessitano di una attenta e complessa analisi sotto il profilo legale. Il livello di coinvolgimento (in termini di risorse finanziarie e di tempo) e il livello di esposizione (in termini di quanto sia sensibile o strategicamente importante il business della JV) dei partecipanti alla JV sono i fattori chiave che influenzano significativamente gli aspetti legali di una JV.
2. Joint ventures contrattuali e societarie
Dal punto di vista giuridico, le JV costituiscono una fattispecie atipica, come tale generalmente non regolamentata dalla legge. Il contratto di JV è di volta in volta strutturato dalle parti in modo da regolamentare la loro collaborazione, definendo le reciproche obbligazioni ed i reciproci diritti, sia in merito al controllo della JV e delle sue attività e sia alla ripartizione dei profitti e dei rischi derivanti dalla collaborazione stessa.
Le imprese partecipanti alla JV (c.d. venturers) non perdono la loro individualità, ma, parallelamente alla partecipazione alla JV, continuano a svolgere autonomamente la propria attività finanziaria o produttiva; per tale motivo, particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti concorrenziali dell’attività propria della JV con l’attività dei singoli venturers (v. par. 4).
Alcuni paesi, in particolar modo in via di sviluppo, hanno adottato specifiche normative in tema di JV, per regolamentare alcuni aspetti della collaborazione, il più delle volte su base societaria- tra un socio locale ed un investitore straniero, generalmente allo scopo di proteggere gli interessi del socio locale ed assicurare un controllo sugli investimenti stranieri, subordinandone l’operatività alla preventiva autorizzazione delle Autorità governative locali.
La prassi ha dato vita a due distinte fattispecie di JV:
- JV contrattuali (contractual JV);
- JV societarie (incorporated o equity JV).
Le JV contrattuali soni accordi associativi atipici fra imprese, di tipo puramente contrattuale. solitamente utilizzate per raggiungere degli obiettivi preventivamente ben individuati e, il più delle volte, destinate a durare esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere tali business targets (ad esempio la realizzazione di una grande opera, la partecipazione ad una gara di appalto internazionale, la distribuzione di beni fra l’esportatore e il concessionario-importatore locale, etc.).
Le JV societarie sono invece accordi tra due o più imprese per mezzo dei quali le stesse, al fine di raggiungere uno scopo comune prefissato, costituiscono una società autonoma e distinta rispetto ai singoli componenti. Nelle JV societarie, il veicolo della collaborazione è rappresentato da una società costituita “ad hoc” (newco), in cui i venturers sono azionisti o quotisti. Le JV societarie sono generalmente alla base di collaborazioni complesse e di più ampio respiro rispetto a quelle cui danno vira le JV contrattuali.
In ogni caso, i venturers, per il solo fatto di aver contratto una JV (contrattuale o societaria) non perdono la loro individualità giuridica ed economica; ciò significa che, parallelamente alla partecipazione alla JV, i singoli venturers continuano a svolgere autonomamente la propria attività finanziaria o produttiva. Per tale motivo, nel contratto di JV uno dei profili più delicati è costituito dalla regolamentazione degli aspetti concorrenziali dell’attività propria della JV in relazione all’attività dei singoli venturers. (v. oltre, par.4)
La scelta a favore di una JV contrattuale, anziché di una JV societaria, si basa spesso su una o più delle seguenti motivazioni:
- carattere informale: la struttura della JV contrattuale è generalmente più informale di una JV societaria, la quale comporta l’adempimento di varie formalità;
- durata limitata: per il suo carattere informale, la JV contrattuale è in genere anche più facile da terminare e da sciogliere, e quindi più adatta per una collaborazione di durata limitata;
- limitazione della responsabilità: lo schermo costituito dalla JV societaria può essere preferibile se le aziende progettano di fornire prodotti o fornire servizi a terzi;
- investimenti congiunti: una JV contrattuale può essere preferibile quando le aziende intendono operare senza investimenti; viceversa, qualora le aziende intendano entrare in un mercato in cui nessuna delle due è presente, può essere auspicabile la costituzione di una JV societaria, anche per fini fiscali;
- creazione o acquisizione di proprietà in comune: se venisse sviluppato un nuovo prodotto, il suo sfruttamento congiunto potrebbe essere più facile con una JV societaria;
- potenziale di profitto: se la cooperazione è un fattore di costo e non è redditizia, i costi e le perdite possono essere pienamente consolidati da entrambe le parti attraverso una JV contrattuale.
3. I passi per la costituzione di una Joint venture
3.1 Lo studio di fattibilità della JV
Esaminiamo ora i principali steps dal punto di vista legale necessari per costituire una JV, contrattuale o societaria.
Preliminare rispetto alla stipula di un contratto di JV è generalmente la redazione di uno studio di fattibilità (feasibility study), nel quale vengono analizzati l’oggetto e le dimensioni dell’investimento che si intende realizzare, le effettive possibilità di realizzazione del progetto comune, della sua convenienza e di ciò che i partners apporteranno all’attività comune.
Solitamente, lo studio di fattibilità viene allegato anche al contratto di JV, costituendo un importante parametro per valutare, in concreto, l’andamento dell’esecuzione del contratto.
A tal fine è opportuno che lo studio di fattibilità indichi, tra l’altro:
- l’investimento complessivo, e come lo stesso verrà effettuato (capitale versato, conferimenti in denaro e in natura, i finanziamenti);
- i macchinari, la tecnologia ed il know-how che si intendono utilizzare;
- il mercato in cui opererà la JV;
- la durata della JV;
- il criterio di distribuzione degli utili;
- le stime del cash flow e del tasso di remunerazione del capitale e della redditività della JV;
- i costi per la formazione del personale.
Normalmente gli studi di fattibilità, pur avendo un contenuto sostanzialmente tecnico ed economico, già racchiudono e suggeriscono, nell’ambito delle soluzioni tecniche, produttive, commerciali e finanziarie in essi individuate, le diverse strutture giuridiche ipotizzabili per costituzione della JV (contrattuale/societaria, paritetica/ con socio in posizione di maggioranza).
Nel caso in cui la JV in corso di valutazione sia di tipo societario e debba operare in un paese estero, il feasibility study dovrà riguardare anche le normative del paese dove la JV company svolgerà la sua attività, al fine di accertare la congruenza tra le le assumptions di business adottate nello studio di fattibilità e le leggi della nazione dove la joint company dovrà tradurre tali assumptions nei risultati che da essa i co-venturers si attendono.
Nella pratica ciò si traduce in una duplice indagine normativa, riguardante:
- la costituzione della joint company locale– ciò si traduce nella verifica delle norme di diritto societario, in vigore nella nazione ove la joint company viene costituita, applicabili quindi al tipo societario prescelto dalle Parti per la joint company che essi intendono costituire, piuttosto che alle disposizioni di legge in materia di tutela della concorrenza o, in molti paesi in via di sviluppo, alle normative in tema di foreign investments (e in questi due ultimi caso solitamente la costituzione della JV presuppone una previa autorizzazione da parte delle autorità competenti);
- l’attività della joint company locale, al fine di valutare il rapporto costi/benefici della prospettata JV company è poi necessario accertare quali ulteriori normative locali possano influenzare l’attività della società locale (norme fiscali, valutarie, doganali, in materia di rapporti di lavoro etc.).
Se siete interessati a scaricare un modello di contratto internazionale di joint venture societaria – international joint venture agreement, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it.
3.2 La lettera di intenti o memorandum of understanding
Generalmente, la redazione del contratto vero e proprio di JV è preceduta dalla sottoscrizione di una lettera di intenti (LOI) o un memorandum of understanding (MOU).
Nella prassi, se correttamente utilizzati, la LOI e il MOU sono accordi che le parti sottoscrivono per organizzare e regolamentare la trattativa che hanno avviato per la costituzione della JV, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione all’effettivo perfezionamento del deal in corso di negoziazione.
Le pattuizioni di una tipica LOI (o MOU) possono essere suddivise in due gruppi:
- il primo, dedicato a definire tempo e modalità della negoziazione ( ad esempio, la lingua che sarà utilizzata per lo scambio di documenti e di proposte, i tempi della contrattazione e il termine ultimo per la stipula dell’accordo);
- il secondo, volto a identificare le caratteristiche, e i limiti, dell’accordo di JV che le parti stanno negoziando, in vista della sottoscrizione del relativo contratto.
Generalmente, le uniche pattuizioni della LOI nelle quali le Parti assumono un impegno giuridicamente vincolante (come tali fonti di responsabilità in caso di violazione) sono:
- la confidenzialità e la riservatezza (non disclosure agreement NDA), rilevanti in quanto spesso le parti si scambiano nel corso della trattativa documenti riservati (progetti di ricerca e sviluppo, processi produttivi brevetti, documenti contabili, etc.) la cui divulgazione potrebbe comportare danni economici elevati;
- la ripartizione dei costi connessi con la negoziazione;
- la durata e recesso;
- la legge applicabile e il sistema di risoluzione delle controversie.
Peraltro, la LOI, anche se generalmente non vincolante – e dunque non fonte di responsabilità in caso di eventuale fallimento delle trattative, incontra in molti ordinamenti giuridici (tra cui quello italiano) il limite del principio di buona fede; qualora dunque una Parte abbia sottoscritto una LOI e avviato le negoziazioni senza avere alcuna intenzione di arrivare alla sottoscrizione di un contratto di JV, ma unicamente per ottenere informazioni riservate attinenti alle attività della controparte o per evitare che questa avvii negoziazioni analoghe con una terza parte, la stessa sarà responsabile nei confronti dell’altra e tenuta al risarcimento del danno.
3.3 Il contratto principale di JV(main agreement)
La complessità di un’operazione di JV fa sì che generalmente la stessa non viene regolamentata con unico contratto, bensì con più contratti tra loro funzionalmente collegati, ovvero:
- un accordo principale (main agreement);
- una serie di accordi collegati (operational o ancillary agreements).
Un unico testo contrattuale, infatti, rende assai difficile individuare e coordinare la molteplicità delle relazioni, giuridiche e commerciali che vengono ad istaurarsi tra i partner e tra ognuno di essi e la nuova società. Inoltre, nel caso delle JV societarie, la sottoscrizione degli accordi in cui è parte la JV company non può essere effettuata nel momento in cui i partner sottoscrivono il contratto di JV , ma quando la nuova società sarà effettivamente costituita.
L’accordo principale di JV (main agreement) regolamenta condizioni, termini e modalità per la costituzione e la gestione comune della JV, individua gli obiettivi della JV, le azioni che questa dovrà intraprendere nel tempo in vista della realizzazione di tali obiettivi, e identificano le relazioni giuridiche che verranno ad instaurarsi tra ognuno dei venturers e la JV.
Indipendentemente dalla forma giuridica, il contratto principale di JV disciplina generalmente i seguenti aspetti:
- definizione di un obiettivo comune delle parti e valutazione dei rischi (giuridici, economici, commerciali) dell’intera operazione;
- la durata della JV (che potrà essere: illimitata con diritto di recesso in capo a ciascun venturer, spesso decorso almeno un certo periodo di tempo o al verificarsi di certi eventi), oppure limitata, eventualmente con rinnovo automatico salvo disdetta; può essere anche individuata una data (o accadimento) decorsa la quale (o verificatosi il quale) ciascun partecipante può chiedere la liquidazione della JV o avviare un processo di vendita dell’intero progetto).
- individuazione e divisione fra le parti dei rispettivi compiti (finanziari, operativi) nella JV;
- individuazione e divisione dei ruoli decisionali parti per la gestione della JV;
- individuazione di un’organizzazione comune di controllo e coordinamento delle prestazioni, al quale partecipano tutti i co-venturers (comitato direttivo o tecnico);
- individuazione di criteri per la partecipazione agli utili e alle perdite;
- limitazioni alla libertà contrattuale delle parti (clausole di confidenzialità, di divieto di concorrenza, di ripartizione dei mercati o comunque di non interferenza, etc);
- individuazione di cause di scioglimento del rapporto (con conseguente liquidazione della società, in caso di JV societaria);
- previsione di “vie di fuga” (exit strategies) che evitino la liquidazione della società ma allo stesso tempo impongano l’acquisto o la vendita delle quote dell’altra parte (sempre in caso di JV societaria).
Nell’accordo principale di JV è di solito contenuta una previsione in base alla quale la risoluzione anticipata del main agreement comporta l’automatica risoluzione dei successivi operational agreements (c.d. clausola di collegamento).
Dal punto di vista operativo viene generalmente predisposto dapprima il JV agreement, e in un secondo tempo vengono concretizzati negli ancillary agreements gli impegni previsti dal primo contratto. Per evitare il rischio che le parti non trovino un consenso sul contenuto degli ancillary agreements, vengono regolamentati nel JV agreement tutti gli aspetti principali, predisponendo come allegati allo stesso almeno una traccia degli ancillary agreements.
In ogni caso, è opportuno prevedere nel JV agreement delle clausole regolanti le conseguenze dello scioglimento anticipato dello stesso a seguito del mancato raggiungimento di un accordo sugli aspetti collaterali della JV. È altresì consigliabile sincerarsi che la JV company non sia costituita prima che questi aspetti siano stati regolamentati.
Il vero e proprio closing dell’operazione avviene comunque solo dopo che la società comune sia stata costituita e la JV abbia ottenuto le eventuali autorizzazioni richieste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili, con particolare riferimento alle normative antitrust.
3.4 Gli accordi accessori (ancillary o operational agrerements)
Parallelamente al contratto principale di JV vengono quindi conclusi una serie di contratti operativi (ancillary o operational agreements), che disciplinano gli obblighi dei venturers rispetto alla JV.
Tali accordi accessori sono particolarmente importanti nel caso di JV societarie, essendo funzionali a individuare e regolamentare gli strumenti che ognuno dei venturers metterà a disposizione della JV company per consentirle di svolgere la sua attività. Tali strumenti possono essere costituiti, oltre che da equity, da know-how, avviamento commerciale, prodotti o servizi, impianti produttivi, licenze e brevetti, risorse umane etc.
Ad esempio, possono essere oggetto dei contratti operativi:
- contratti di finanziamento e relative garanzie reali e personali;
- contratti di appalto o accordi con i fornitori;
- lo statuto e i patti parasociali della JV;
- licenze di tecnologia o marchio;
- fornitura o concessione di prodotti, materie prime, strumenti o attrezzature;
Tra tali accordi assumono notevole importanza le clausole di warranties and representations, le quali consistono in reciproche rassicurazioni di impegno che i venturers assumo tra loro e nei confronti della JV societaria. Ad esempio, nel caso in cui un venturer fornisca alla nascente società un particolare tipo di tecnologia da applicarsi al ciclo produttivo della JV, lo stesso si impegna a continuare i propri progetti di sviluppo della tecnologia fornita alla compagine societaria ed a mettere a disposizione della JV gli eventuali sviluppi positivi che potrebbero migliore la produzione ed aumentare il profitto della comune impresa
A garanzia degli impegni assunti possono essere previsti indennizzi anche di notevole entità a carico del venturer infedele e a favore della JV. Può inoltre essere previsto che nel caso in cui un venturer apporti una miglioria all’impresa comune. determinando un incremento notevole del profitto (o un notevole abbattimento dei costi di produzione), venga rinegoziata la ripartizione degli utili, in modo da garantire una migliore soddisfazione al venturer stesso.
4. Obblighi di non concorrenza ed esclusiva
Spesso gli accordi di JV prevedono obblighi di non concorrenza durante la durata della JV. Le clausole di non concorrenza inserite nell’accordo principale sono generalmente finalizzate non già a limitare la concorrenza tra i venturers nei rispettivi mercati, bensì a limitare la concorrenza dei ventures con la JV da loro costituita. Tali limitazioni possono essere previste per determinate categorie di prodotti oppure per determinate aree geografiche.
Tali divieti possono assumere una varietà di contenuti. Ad esempio può essere previsto:
- un divieto per i venturers di svolgere attività rientrante nella stessa area di business della JV, riservando tutte le attività alla JV;
- un divieto per i venturers di competere direttamente con una determinata attività della JV;
- l’obbligo dei venturers di non sollecitare affari, o fare affari, con clienti della JV;
- l’obbligo dei venturers di non assumere dipendenti della JV;
etc.
Se l’accordo di JV prevede l’impegno di ciascun partner a non competere con la JV nelle sue aree di attività, ciascuna parte vorrà garantire che l’ambito di tali impegni di non concorrenza o di esclusività sia controllabile/gestibile e non possa essere ampliato o limitato unilateralmente da un’altra parte. I mezzi che vengono spesso impiegati per ottenere questo risultato includono:
Se l’accordo di JV prevede l’impegno di ciascun partner a non competere con la JV nelle sue aree di attività, ciascuna parte vorrà garantire che l’ambito di tali impegni di non concorrenza o di esclusività sia controllabile/gestibile e non possa essere ampliato o limitato unilateralmente da un’altra parte. I mezzi che vengono spesso impiegati per ottenere questo risultato includono:
- Piano aziendale concordato: Le parti concordano un business plan per i primi anni della JV e si impegnano ad aggiornarlo di volta in volta di comune accordo. Il piano industriale affronterà, oltre al piano finanziario, anche alcune decisioni strategiche (per esempio, R&S/linea di prodotti/mercati) che costituiscono la base dell’attività della JV. Ciò dovrebbe garantire che la JV non si impegnerà in attività che non sono state concordate delle parti.
- Diritti di veto sulle estensioni di attività: viene previsto un diritto di veto su qualsiasi decisione che porti ad un ampliamento dell’attività della JV, in particolare su decisioni riguardanti le linee di prodotti, l’ingresso in nuovi mercati e l’uso o lo sviluppo di nuove tecnologie.
- Ritagli per sotto-performance: se la JV si rivela infruttuosa rispetto a determinati mercati o clienti dopo un certo periodo di tempo, le parti potrebbero voler essere attivi in tale mercato o cliente senza coinvolgere la società di JV, a causa di difficoltà tecniche o esigenze di un cliente specifico. Per evitare che i venturers subiscano danni in un tale scenario, si possono prevedere alcuni limiti e deroghe agli obblighi di non concorrenza ed esclusiva, ad esempio che tali impegni cessino di applicarsi rispetto a mercati, territori o clienti specifici se il fatturato della JV rispetto a tali mercati/ territori/clienti scende al di sotto di una certa soglia durante un determinato periodo di tempo. Oppure si può prevedere un diritto di prelazione della JV su nuove attività nell’ambito dell’attività prestabilita, con possibilità delle parti di perseguire tale opportunità se la JV non esercita la prelazione.
Nella prassi, spesso i contratti di JV prevedono limiti ai singoli venturers circa la possibilità di alienare a terzi della propria quota di partecipazione nella JV. Tale previsione –in linea con la natura stessa della JV, che si basa sugli specifici apporti (scientifici, tecnologici, economici e finanziari) spesso infungibili dei singoli partecipanti – è generalmente temperata con la previsione di un diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti oppure con la previsione che il venturer possa uscire dalla JV soltanto dopo un determinato periodo di tempo (cd. lock up clause).
5. Proprietà intellettuale
In sede di costituzione della JV, uno o più partecipanti potrebbero conferire marchi, brevetti, know-how o altri diritti di privativa, i quali divengono di proprietà del nuovo soggetto giuridico. In tal caso, in sede di liquidazione della società, il partecipante già titolare di tali diritti non ha diritto alla loro assegnazione ma avrà, al pari degli altri soci e in ipotesi di presenza di un attivo di liquidazione, un diritto di credito nei confronti della società.
In alternativa, se l’impresa partecipante ha interesse a vedersi re-intestare i diritti di privativa conferiti, il diritto di sfruttamento della proprietà industriale può essere oggetto di licenza alla JV, anziché di trasferimento in proprietà.
In tal modo, il venturer può continuare a sfruttare il marchio per la commercializzazione di prodotti diversi da quelli concessi in licenza alla JV, o in altri territori. Il venturer mantiene inoltre il controllo sul perseguimento e il mantenimento della registrazione della proprietà intellettuale ed è l’unico soggetto che può far valere i diritti di proprietà intellettuale contro i terzi. Si può prevedere che il licenziante abbia diritto di revocare la licenza in caso di violazione da parte della JV.
Se le attività della società di JV richiedono alle parti di conferire o concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale significativi alla JV, le stesse vorranno assicurarsi di mantenere un certo livello minimo di controllo su tali diritti, sia durante l’attività della JV che in uno scenario di exit.
Inoltre, sarà importante che tali parti si assicurino di possedere o almeno controllare i diritti di proprietà intellettuale sviluppati di recente dalla società di JV sulla base dei diritti di proprietà intellettuale originariamente conferiti. Se la proprietà intellettuale materiale è conferita o sviluppata dalla società di JV, l’accordo di JV dovrà contenere disposizioni che disciplinano la proprietà e i diritti di utilizzo di tale proprietà intellettuale durante la durata della JV, e in particolare alla sua cessazione.
Tipicamente, la parte che contribuisce alla proprietà intellettuale di base per ulteriori sviluppi della società di JV, vorrà assicurarsi di avere il diritto esclusivo di proprietà intellettuale al momento della cessazione della JV.
6. Le JV societarie
Con il termine di JV societarie, come si è visto, si indicano forme di associazione temporanee di imprese finalizzate all’esercizio di un’attività economica in un settore di comune interesse, nelle quali le parti prevedono appunto la costituzione di una società di capitali, con autonoma personalità giuridica.
Nel caso delle JV societarie si ha dunque la nascita di una nuova società in cui lo schema societario assolve una funzione strumentale rispetto al sottostante accordo di JV, nel quale, in ogni caso, trova la sua fonte.
La JV societaria è generalmente costituita mediante la costituzione di una società con conferimento (o, più raramente, vendita) alla stessa da parte dei partecipanti di determinati beni (denaro, proprietà industriale, attrezzature, rapporti commerciali, etc.). Frequentemente, qualora i beni che i partecipanti intendono conferire siano già organizzati per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, il conferimento ha ad oggetto un ramo di azienda, cosicché ogni impresa trasferisce un ramo di azienda a una società di nuova creazione, ricevendo in cambio le partecipazioni sociali, nella misura che sarà stata determinata nell’accordo di JV.
In alternativa, è possibile procedere a una fusione (propria o per incorporazione) delle imprese dei partecipanti, mediante la quale questi ultimi decidono, in via definitiva, di mettere in comune l’intera loro attività.
In entrambe le modalità di costituzione della JV, è opportuno valutare con attenzione il regime di responsabilità del nuovo soggetto giuridico così costituito per le eventuali passività pregresse dei suoi danti causa. Sia nell’ambito del conferimento di ramo di azienda (cfr. gli artt. 2112 e 2560 c.c.) sia nella fusione (cfr. art. 2504 c.c.), seppur con regimi e limiti differenti, il nuovo soggetto giuridico risponde infatti dei debiti dei conferenti o delle società partecipanti alla fusione.
Un contratto di JV societaria prevede tipicamente le seguenti pattuizioni:
- motivazioni che hanno spinto i venturers a costituire la JV, risultati che le parti si propongono di raggiungere specifici obiettivi assegnati alla JV;
- tipologia societaria della JV company, sede e denominazione, capitale sociale e quote di partecipazione dei singoli venturers, tempistiche e modalità di sottoscrizione del capitale sociale, contributi e relative garanzie offerte, eventuali condizioni al verificarsi delle quali è subordinato il closing e l’avvio delle attività della JV, rapporti che la JVCo instaurerà con i singoli venturers;
- criteri concordati tra i venturers per la gestione della JV (patti parasociali), ovvero: modalità e criteri per la convocazione, quorum e funzionamento degli organi sociali della JV, nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, criteri per la nomina dell’Amministratore Delegato e dei principali managers della JV, poteri e deleghe loro attribuiti, clausole poste a tutela del venturer di minoranza e identificazione delle decisioni che possono essere assunte dalla JV soltanto con il voto favorevole di entrambi i venturers, gestione finanziaria e amministrativa, politica dei dividendi, debt-equity ratio (indebitamento finanziario netto v. patrimonio netto) che la JV dovrà rispettare;
- risoluzione delle eventuali controversie tra i venturers in merito alle attività della società comune, e, nell’eventualità che il deadlock rimanga irrisolto, modalità per consentire l’uscita (exit) dei venturers, (opzioni put o call).
7. Organi della JV
Uno degli aspetti cruciali da regolamentare è quello relativo alla struttura e poteri degli organi sociali della JV company.
Le parti tendono spesso a organizzare la società di JV utilizzando una struttura di gestione a due livelli:
- da un lato, il consiglio di amministrazione, composto dal personale apicale di ciascun gruppo di partner di joint venture, con responsabilità primaria delle decisioni strategiche e altre decisioni materiali che può avere un impatto finanziario significativo sul futuro della JV;
- dall’altra parte, la direzione esecutiva con la responsabilità generale degli aspetti operativi quotidiani della JV e, che non è necessariamente composta in modo uguale, ma principalmente sull’esperienza del settore pertinente, sul know-how tecnico, sulle competenze e sulla rete locali.
Uno degli aspetti principali che deve essere disciplinato dal JV main agreement è il processo decisionale della JV in merito alle strategie ed alle singole operazioni che la JV societaria dovrà perseguire o compiere. La natura normalmente dinamica dell’attività produttiva ed economica delle imprese può infatti determinare la necessità di compiere scelte che, inizialmente, non erano prevedibili. Si pensi, ad esempio, ad una modifica legislativa del Paese in cui è stata costituita la JV, tale da comportare limiti alla distribuzione degli utili in favore di un socio oppure una diversa tassazione di tali profitti.
Spesso nel main agreement viene previsto, soprattutto a tutela dei venturers di minoranza, che determinate decisioni siano assunte non a maggioranza ma all’unanimità dei partecipanti oppure a maggioranza qualificata. Tra le materie straordinarie per le quali occorrono maggioranze qualificate o, addirittura, l’unanimità – oppure che attribuiscono a uno dei partner dei diritti di veto- rientrano solitamente mutamenti strutturali alla JV (ingresso di nuovi partecipanti, ampliamento dell’ambito di attività, varo di aumenti di capitale, liquidazione della società che incorpora la joint venture), la modifica del business plan, l’approvazione di investimenti e l’assunzione di indebitamento o il rilascio di garanzie superiori a determinate soglie, la costituzione di società partecipate, l’assunzione di top manager.
Sono a tal proposito frequenti le clausole statutarie o i patti parasociali che prevedono vincoli alla trasferibilità delle azioni (clausole di gradimento) e diritti di prelazione. Successivamente all’esercizio di eventuali diritti di prelazione, e in alternativa a clausole di gradimento, possono essere inseriti diritti di co-vendita (tag-along e drag-along), i quali consentono di aver adeguata certezza della sorte della propria partecipazione, indipendentemente dall’entità di questa.
Le clausole Tag-Along prevedono il diritto del socio a profittare delle condizioni ottenute dal socio di maggioranza in caso di vendita; il soggetto intenzionato a cedere la propria partecipazione potrà farlo a condizione di ottenere dal suo acquirente l’impegno all’acquisto delle residue quote alle medesime condizioni a lui riconosciute. Sono poste a tutela della minoranza, in quanto evitano al titolare del diritto di essere obbligato a diventare co-partner di terzi non graditi.
Le clausole Drag-Along attribuiscono invece al partner trasferente il diritto di obbligare quello non trasferente ad alienare al terzo anche la sua partecipazione, in tal modo, il socio cedente (di maggioranza) è in grado di meglio negoziare la vendita della società target avendo diritto di trasferire l’intero capitale sociale e quindi di evitare il possibile non gradimento del socio di minoranza da parte del terzo potenziale acquirente o comunque i poteri di veto esercitabili dal socio di minoranza
Nell’amministrazione ordinaria della JV sarà possibile prevedere deleghe gestionali con firme disgiunte, ad esempio fino a determinate soglie, prevedendo uno specifico budget e stabilendo chi si deve occupare dei singoli aspetti. È opportuno chiarire il peso decisionale spettante a ciascun partner, con approcci che possono oscillare tra un modello cooperativo (“una testa, un voto”), sino al sistema in cui un partecipante ha un peso preponderante a prescindere dalle quote che possiede giungendo al frequente caso in cui i poteri sono distribuiti in funzione dell’apporto di capitale relativo.
8. Dead-lock
A differenza di quel che accade nelle normali società di capitali, il vincolo societario rappresenta il mezzo, ma non lo scopo ultimo della JV, il cui presupposto essenziale (o almeno uno dei presupposti essenziali) è rappresentato dalla complementarietà degli apporti dei singoli venturer, ognuno dei quali, quand’anche in misura disuguale, è di solito indispensabile al buon esito delle attività della JV e più in generale al successo della JV.
Per tale motivo, spesso si prevede che contratto determinate decisioni possano essere approvate soltanto con il consenso del venturer di minoranza, quale che sia, quantomeno entro certi limiti, la sua partecipazione nella JV. In caso di disaccordo tra i venturers il rischio è che la necessità di una simile condivisione decisionale possa portare ad uno stallo (dead-lock) nelle attività della JV.
Lo stallo decisionale (dead-lock) si ha appunto quando, in mancanza del raggiungimento dell’unanimità (oppure di una maggioranza qualificata) nel consiglio di amministrazione della JV (alla quale partecipano i rappresentanti dei singoli venturers), la società non riesce ad adottare una decisione determinante per la prosecuzione dell’attività comune.
Sono frequenti le clausole statutarie, improntate ad una gradualità di misure, che mirano ad evitare che l’operatività della società sia bloccata dal dissenso di un co-partner su alcune decisioni operative importanti.
Si può prevedere ad esempio che ove i partners non siano in grado di risolvere l’impasse, in una prima fase si cerchi di raffreddare (cooling-off) la divergenza di opinioni, imponendo all’organo competente di riesaminare la questione controversa, dopo un nuovo approfondimento e sulla base di pareri e proposte di collaboratori o esperti esterni, ovvero portando la decisione ad un diverso livello decisionale (ad esempio, il CdA rispetto al comitato esecutivo; l’assemblea dei soci rispetto al CdA).
In una successiva fase si può prevedere che la decisione venga rimessa ad esperti, incaricati di trovare la soluzione più opportuna, con poteri decisionali o semplicemente propositivi (in tal caso, il buon esito è affidato alla capacità degli esperti di indicare una soluzione che convinca tutte le parti).
Vi sono inoltre diverse soluzioni adottabili per risolvere situazioni di dead-lock.
In base alla c.d. “move up clause”, in caso di dead-lock, uno dei venturer invia all’altro (o agli altri), una dead-lock notice, vale a dire, una comunicazione con cui si avvisano gli altri partecipanti della fase di stallo verificatasi nel CdA della JV. A questo punto si apre un dialogo non più tra i rappresentanti dei venturers in sede di CdA della JV, ma direttamente tra gli amministratori delegati dei venturers (o tra soggetti da questi individuati, oppure tra i legali rappresentanti delle imprese coinvolte nella JV), i quali coopereranno, nei tempi previsti dal main agreement, al fine di superare la fase di stallo e proseguire l’attività comune.
La cd “way out clause”, in caso di conflitto irrisolvibile, disciplina la cessione da parte di un venturer della propria quota di partecipazione all’altro venturer o agli altri venturers, prevedendo anche i criteri di liquidazione e tempi della procedura. A tal proposito sono frequenti le previsioni in base alle quali una delle parti ha diritto di vendere o acquistare la propria partecipazione (put/call option) in base a prezzi e modalità predeterminate.
9. Scioglimento della JV ed exit
Un altro aspetto importate è quello dello scioglimento della JV e delle possibili exit strategies. Soprattutto nei casi in cui venga costituita una JV con partners stranieri (investitori istituzionali o partner industriali), con il tempo l’apporto dei partners locali si può rivelare non adeguato, o le condizioni sopravvenute del mercato possono richiedere ai co-venturer un rinnovato e ulteriore impegno che alcuni (o tutti) non sono disposti a sostenere.
In questi casi, non è opportuno che la società venga messa in liquidazione, in quanto ciò comprometterebbe gli elementi economici rilevanti sostenuti. Il problema può essere risolto stabilendo una clausola di way out, che prevede e disciplina in modo vincolante, al ricorrere di determinate circostanze, l’uscita di uno o più soggetti dalla compagine dei partners che partecipano alla JV.
Più precisamente, tale clausola può regolamentare:
- l’uscita del partner nel cui favore la clausola sia predisposta; egli non sarà obbligato a trovare un terzo compratore, ma potrà cedere le proprie quote, ad un prezzo vincolato, agli altri partner, i quali si impegnano ad acquistarne la partecipazione (opzione put, ovvero proposta irrevocabile di acquisto);
- l’uscita del partner contro il quale la clausola sia predisposta; egli potrà essere costretto a cedere le proprie quote agli altri partner o a un terzo, ad un prezzo vincolato (opzione call, ovvero proposta irrevocabile di vendita)
Tali ipotesi possono essere e sono normalmente combinate, con facoltà di scelta attribuita alla Parte nel cui favore la clausola sia predisposta.
Se siete interessati a scaricare un modello di contratto internazionale di joint venture societaria – international joint venture agreement, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it.
Per approfondire i nostri servizi di assistenza e consulenza in tema di contratti commerciali, visionate la pagina dedicata del nostro sito .
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in Diritto societario
Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.
Le informazioni contenute in questo articolo sono da considerarsi sino alla data di pubblicazione dello stesso; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.