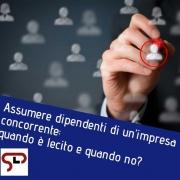Il contratto di licenza di uso del marchio (licensing)
Con il contratto di licenza (licensing), il titolare di un marchio concede in uso tale bene a un terzo, dietro pagamento di un corrispettivo, senza privarsi della titolarità di tali diritti. Il licensing del marchio è molto diffuso in tutto il mondo e presenta molteplici vantaggi, sia per il licenziante che per il licenziatario. Il contratto di licenza di marchio ha natura atipica, cioè non è regolamentato da una normativa di legge bensì dalle parti stesse; per tale motivo, tale contratto deve essere redatto in modo attento e adeguato. Pur nella varietà dei contenuti che un contratto di licenza di marchio può assumere, nella prassi vi sono alcune clausole tipiche che regolamentano la licenza di marchio.
1. Cos’è la licenza di uso del marchio
Con il contratto di licenza (licensing), il titolare di un marchio concede in uso tale bene a un terzo, dietro pagamento di un corrispettivo, senza privarsi della titolarità di tali diritti. Il licenziante, infatti, resta titolare del marchio, concedendolo però a terzi il diritto di utilizzarlo, a determinate condizioni e per un certo periodo di tempo.
Come si è visto in un precedente articolo, il licensing del marchio, e più in generale di diritto di proprietà intellettuale o di tecnologia, è molto diffuso in tutto il mondo è presenta molteplici vantaggi, sia per il licenziante che per il licenziatario.
Grazie al licensing il titolare del marchio può infatti “sfruttare” economicamente il proprio diritto di privativa intellettuale, senza privarsi della titolarità dello stesso e senza sostenere ulteriori investimenti. In particolare nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di moda, il contratto di licenza di marchio consente all’impresa titolare del marchio di ridurre i costi fissi che sarebbero imposti dall’acquisto o locazione di macchinari e dall’assunzione della manodopera specializzata necessaria per la loro realizzazione.
Inoltre, concedendo a terzi la licenza di uso del marchio il titolare può ampliare lo sfruttamento del marchio anche in territori in cui il licenziante non è attivo, con conseguente maggiore notorietà e ,quindi, un aumento di valore del marchio stesso.
D’altra parte, il licenziatario può, godere dell’avviamento ottenuto dal licenziante nel corso degli anni, ampliando così il proprio volume d’affari, senza dover sostenere non dovrà sostenere alcun investimento per la ricerca, lo sviluppo e/o la realizzazione del marchio.
Ben si comprende, dunque, come il licensing sia un accordo di cooperazione, piuttosto che di competizione, tra due imprese, mirato al raggiungimento di un fine comune e di vantaggio economico sia per il licensor che per il licensee.
Il contratto di licenza ha natura atipica, il che significa che non è regolamentato da una normativa di legge bensì dall’autonomia privata, ovvero dalle parti stesse nel contratto. Per tale motivo, un contratto di licenza di marchio deve essere attentamente ed adeguatamente redatto.
Pur nella varietà dei contenuti che un contratto di licenza di marchio può assumere, sono riscontrabili alcune clausole tipiche e ricorrenti. Vediamo in sintesi le principali.
2. L’oggetto della licenza e la durata
Con il contratto di licenza di uso del marchio, si formalizza la concessione dal licenziante al licenziatario del diritto di utilizzare, per un certo periodo di tempo, il marchio del licenziante, con determinate modalità e con riferimento a determinati prodotti.
Spesso, unitamente alla licenza di uso del marchio si prevede il diritto/obbligo del licenziatario di fabbricare e/o distribuire i prodotti in relazione ai quali viene utilizzato il marchio. Tale diritto può avere estensioni diverse: ad esempio, il licenziante può concedere al licenziatario il diritto di fabbricare i prodotti in determinato un paese, e il diritto di venderli in un altro. Generalmente, il licenziante ha interesse a limitare l’utilizzo del marchio da parte del licenziatario, in modo tale da impedire eventuali abusi o atti che ne possono ledere i diritti e diminuirne il valore.
Generalmente il licenziatario è tenuto ad attenersi, nella produzione, nel confezionamento e nelle modalità di distribuzione del dei prodotti licenziati, a determinati standards tecnici e/o di qualità stabiliti dal licenziante. Spesso si prevede la facoltà del licenziante di accedere ai luoghi di produzione del licenziatario per controllare l’andamento dei lavori e per assistere all’esecuzione di tests sui prodotti licenziati. Talvolta si prevede anche l’impegno del licenziante ad assistere il licenziatario nella ricerca di difetti, misure necessarie per correggerli, eliminarli o prevenirli, a fronte del correlativo impegno del licenziatario a riconoscere in favore del licenziante un certo compenso.
Deve inoltre essere stabilito il territorio di riferimento; la licenza di uso del marchio può essere infatti concessa limitatamente a una determinata nazione o regione, impedendo al licenziatario di sfruttare il titolo al di fuori della zona stabilita.
Infine, deve essere stabilita la durata del contratto di licenza. Generalmente, la licenza di un marchio viene concessa per un periodo di tempo che va dai 2 anni ai 5 anni; può essere tuttavia più breve o più lunga, in base agli accordi tra le parti. Le parti possono inoltre prevedere che alla (prima) scadenza del contratto questo si rinnovi automaticamente, per un uguale o diverso periodo di tempo, salvo disdetta delle parti, da darsi entro un certo periodo di tempo prima della scadenza. In mancanza di tale previsione, il contratto cessa i suoi effetti alla prima scadenza convenuta.
Se siete interessati a scaricare un modello di contratto di licenza di uso di marchio, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it
3. Uso del marchio, riservatezza, promozione e pubblicità
Il licenziatario è generalmente obbligato a fare uso del marchio al meglio delle proprie possibilità; ciò non solo al fine di spingere il licenziatario ad aumentare, e non a far scendere, la notorietà del marchio all’interno del territorio contrattuale, ma anche al fine di evitare di incorrere nella sanzione (prevista dalla maggioranza dei Paesi industrializzati) della decadenza del marchio in seguito al suo mancato o insufficiente sfruttamento per un certo periodo.
Spesso si prevede l’impegno del licenziatario a non depositare o far depositare il marchio concesso in licenza o altri segni distintivi del licenziante, sia nel territorio contrattuale che altrove, nonché registrare o utilizzare, direttamente o indirettamente, altri segni che possano essere confusi con quelli del licenziante.
L’interesse del licenziante di salvaguardare al massimo il valore economico del marchio e prevenire l’eventualità che, per mezzo del licenziatario, questo venga in possesso della concorrenza, porta solitamente ad inserire nel contratto di licenza una clausola di riservatezza, con cui si prevede l’impegno del licenziatario, sia durante la valenza del contratto sia anche dopo la sua cessazione, a non divulgare né utilizzare, per fini che esulano dal rapporto contrattuale, il marchio ed ogni altra informazione riservata che gli è stata comunicata dal licenziante.
Il marchio conferisce caratteristiche intrinseche al prodotto su cui è apposto, e cioè una valenza suggestiva e relative capacità di veicolazione della clientela; è pertanto opportuno che tutti i prodotti licenziati e contraddistinti con il marchio si presentino ai consumatori con la stessa immagine pubblicitaria.
Di solito è quindi presente una clausola con cui vengono sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta del licenziante tutti i contenuti, le forme e modalità delle attività promozionali e pubblicitarie. Può essere inoltre previsto che le spese relative a tali attività vengano sostenute totalmente dal licenziatario, con l’impegno di quest’ultimo ad investire un importo annuo non inferiore ad una certa percentuale del fatturato realizzato con la vendita del prodotti licenziati.
4. Responsabilità del licenziante e tutela del marchio
Il licenziante, che solitamente detiene un più forte potere contrattuale rispetto al licenziatario, ha l’interesse a limitare la propria responsabilità in ordine al marchio concesso in uso al licenziatario. Il licenziante quindi normalmente non garantisce la validità del marchio, ma si limita a garantire:
- la veridicità delle dichiarazioni circa lo stato del marchio; che seguirà diligentemente le pratiche di deposito della domanda di registrazione e concessione del marchio, senza garantire anche la concessione;
- che non esistono instaurati procedimenti di decadenza o nullità, marche non sono in corso procedimenti di contraffazione;
- di non essere a conoscenza di diritti di terzi che possano essere violati dal proprio marchio.
Al fine di prevedere in anticipo una adeguata tutela al proprio marchio, il licenziante generalmente stabilisce nel contratto la politica che dovrà essere seguita in caso di atti di contraffazione all’interno del territorio contrattuale.
Qualora il territorio sia distante dal licenziante o comunque la gestione diretta della azione di contrasto alla contraffazione comporterebbe costi troppo elevati, viene affidato al licenziatario il compito di tenere sotto controllo la concorrenza ed il mercato di riferimento e di agire di conseguenza, in autonomia, magari prevedendo obblighi di relazioni e di preventive autorizzazioni circa le linee guida da seguire.
Se invece il licenziante intende tenere personalmente le redini della propria politica di anti-contraffazione del marchio nel territorio contrattuale, ad esempio per mantenere una uniformità tra i vari paesi nei quali il marchio viene licenziato, al licenziatario vengono attribuiti solo compiti di sondaggio del mercato e di informativa circa possibili violazioni del marchio, oltre a doveri di collaborare e assistere attivamente il licenziante nelle azioni che questi vorrà intraprendere.
5. Il corrispettivo della licenza
Il contratto di licenza di marchio è a titolo oneroso, ovvero prevede la corresponsione di un corrispettivo dal licenziatario al licenziante per l’utilizzo del marchio. L’ammontare del corrispettivo è definito dalle parti; esso dipende da una serie di fattori, quali l’importanza e il valore del marchio concesso in licenza, il grado di protezione del marchio, l’eventuale fornitura di servizi ulteriori da parte del licenziante, la situazione del mercato di riferimento, etc., In alcuni casi può essere utile ricorrere, per la determinazione del corrispettivo della licenza di marchio, ad una valutazione peritale di stima, ovvero ad una perizia del marchio, tramite la quale è possibile conoscere il valore economico del marchio stesso.
Il corrispettivo per la licenza del marchio può essere anche non monetario, come nel caso del cross licensing (corrispettivo costituito da tecnologia) o quando il corrispettivo è in natura (ad esempio, attrezzature o commesse di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario).
Quando invece il corrispettivo della licenza è monetario, esso può essere fisso o variabile. Nel primo caso (lump sum), il corrispettivo viene pagato una tantum, indipendente dall’entità dei profitti realizzati dal terzo licenziatario. Il corrispettivo variabile è invece costituito dalla royalty, che è la forma di quantificazione del corrispettivo più diffusa nei contratti di licenza.
Le royalties possono essere determinate in base agli utili ricavati dalle vendite del licenziatario, cioè sul prezzo di vendita, lordo o netto (può essere previsto un fair market price, cioè un prezzo ritenuto dalle parti equo per il prodotto offerto in vendita), o in base alla produzione del licenziatario, cioè sul fatturato (come importo fisso per ogni unità di prodotto oppure per determinate quantità di prodotti), o ancora sulla partecipazione agli utili dell’impresa del licenziatario (soprattutto quando il licenziante ha la possibilità di influire sulla direzione dell’impresa del licenziatario, ad esempio con un contratto di joint venture o in un gruppo di società).
Spesso, sia per la determinazione o verifica delle royalties, sia per altri fini, si prevede nel contratto di licenza un onere di rendicontazione da parte del licenziatario circa l’andamento delle vendite, e la possibilità del licenziante di monitorare l’andamento del licenziatario, attraverso audit. La procedura di audit deve essere attentamente disciplinata nel contratto per evitare che possa essere sfruttata a fini strumentali da parte del licenziante, ad es. prevedendo che i relativi costi sono a carico del licenziante se all’esito dell’audit l’under reporting è inferiore ad una certa percentuale fisiologica.
6. L’esclusiva
La licenza di marchio può essere a titolo esclusivo o non esclusivo. La licenza esclusiva ha ad oggetto la totalità dei prodotti o servizi e dell’intero territorio per i quali è stato registrato il marchio; in questa ipotesi, il contratto conferisce al solo licenziatario la facoltà di utilizzare il marchio, che quindi non può essere sfruttato non solo da altri soggetti terzi ma neppure dal titolare del marchio stesso.
Se le parti intendono garantire al licenziatario una licenza esclusiva, devono menzionarlo espressamente nel contratto; in assenza di tale precisazione, la licenza si intende non esclusiva.
La licenza d’uso esclusivo di un marchio può essere concessa per la totalità dei prodotti e servizi o solo per una parte. In quest’ultimo caso ricorre il c.d. contratto di merchandising, con il quale il titolare di un marchio che gode di rinomanza concede in uso esclusivo lo stesso in relazione a prodotti appartenenti a settori merceologici diversi da quelli per cui il marchio era stato originariamente registrato, e messi in commercio dal concedente. Nell’ipotesi di licenza esclusiva di uso parziale del marchio è quindi necessario che la licenza riguardi un’intera categoria di prodotti affini, al fine di evitare interferenze fra marchi utilizzati da imprenditori diversi.
Con la licenza non esclusiva, invece, il titolare del marchio, pur concedendone il diritto di sfruttamento in relazione a certi prodotti in un determinato territorio, conserva questa facoltà anche per sé stesso, oppure può concedere più licenze a diversi soggetti in relazione agli stessi prodotti e nel medesimo territorio.
In tal caso, poiché possono circolare nel mercato con lo stesso marchio prodotti uguali ma provenienti da imprenditori diversi, l’art. 23 del D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) prevede che il licenziatario deve assumere contrattualmente l’impegno di uniformare la propria produzione su cui appone il marchio a quella del titolare del marchio o a quella degli altri licenziatari; in sostanza, nel caso di concessione di una licenza non esclusiva, lo stesso prodotto, seppure proveniente da più imprese, deve presentare le medesime qualità.
È verosimile, infatti, che il consumatore, abituato ad un prodotto contraddistinto da determinate qualità, si aspetti di ritrovarle anche sugli altri prodotti identici che recano lo stesso marchio. Per tutelare l’affidamento del pubblico, la legge prevede dunque che il licenziatario deve essere tenuto contrattualmente ad usare il marchio per prodotti uguali, quanto a qualità e caratteristiche, a quelli del titolare del marchio stesso e degli altri licenziatari.
Dovrà essere quindi prevista nel contratto di licenza di uso del marchio una clausola con cui al titolare del marchio viene riconosciuto il potere di controllare e dirigere l’attività (produttiva, commerciale, distributiva ecc.) del licenziatario, al fine di ottenere una uniformità di tutte le produzioni poste in essere dai singoli licenziatari.
Viene inoltre regolato nel contratto se il licenziatario ha il diritto o meno di concedere sub-licenze e/o di utilizzare terzi per la fabbricazione, totale o parziale, dei prodotti licenziati. Qualora il licenziante conceda tale facoltà, di solito si prevede un controllo ed una approvazione preventiva dei nominativi dei sub-licenziatari, e che comunque il licenziatario dovrà imporre a sua volta l’esclusiva a suo favore sui sub-licenziatari.
Se siete interessati a scaricare un modello di contratto di licenza di uso di marchio, inviate una mail al seguente indirizzo: info@studio-pandolfini.it.
Per approfondire i nostri servizi di assistenza e consulenza in tema di diritto industriale, visionate la pagina dedicata del nostro sito .
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Contrattualistica d’Impresa
Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il diritto d’impresa: visitate il nostro blog.
Le informazioni contenute in questo articolo sono da considerarsi sino alla data di pubblicazione dello stesso; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni riportate nell’articolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Di conseguenza, il presente articolo non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.